 Il cuore è italiano, ma testa e gambe sono sempre più francesi. È il destino del settore food & luxury tricolore, sempre più oggetto di scorribande da parte dei cugini d’oltralpe e non solo. Le acquisizioni della Pasticceria Cova di Milano e di Loro Piana da parte di LVMH sono solo le ultime di una lunga serie, con perle dal nome di Gucci, Bulgari e Fendi, tanto per citare i più noti, già finiti in mani transalpine. Per non parlare del settore energia. Gli sciovinisti del giorno dopo gridano alla disgregazione del made in Italy, evocando la desertificazione industriale e l’oltraggio al nostro prestigio imprenditoriale. Quasi che si riproponesse la campagna d’Italia del 1796, in cui Napoleone razziò il nostro Paese delle migliori opere d’arte, esibite ai parigini come trofeo di guerra. Cari amici, questo è il mercato. Piuttosto che abbaiare alla luna, vale forse la pena fare un po’ di autocritica. Per quali ragioni le nostre aziende sono diventate prede fragili e indifese? Perchè non riusciamo ad essere a nostra volta predatori? E’ tutta e solo colpa di un “sistema Paese” che non aiuta – ed anzi spesso ostacola – lo sviluppo delle sue imprese? Non solo. E’ sufficiente osservare i nostri difetti, quello che dovremmo essere e che ancora non siamo.
Il cuore è italiano, ma testa e gambe sono sempre più francesi. È il destino del settore food & luxury tricolore, sempre più oggetto di scorribande da parte dei cugini d’oltralpe e non solo. Le acquisizioni della Pasticceria Cova di Milano e di Loro Piana da parte di LVMH sono solo le ultime di una lunga serie, con perle dal nome di Gucci, Bulgari e Fendi, tanto per citare i più noti, già finiti in mani transalpine. Per non parlare del settore energia. Gli sciovinisti del giorno dopo gridano alla disgregazione del made in Italy, evocando la desertificazione industriale e l’oltraggio al nostro prestigio imprenditoriale. Quasi che si riproponesse la campagna d’Italia del 1796, in cui Napoleone razziò il nostro Paese delle migliori opere d’arte, esibite ai parigini come trofeo di guerra. Cari amici, questo è il mercato. Piuttosto che abbaiare alla luna, vale forse la pena fare un po’ di autocritica. Per quali ragioni le nostre aziende sono diventate prede fragili e indifese? Perchè non riusciamo ad essere a nostra volta predatori? E’ tutta e solo colpa di un “sistema Paese” che non aiuta – ed anzi spesso ostacola – lo sviluppo delle sue imprese? Non solo. E’ sufficiente osservare i nostri difetti, quello che dovremmo essere e che ancora non siamo.
Primo aspetto. L’imprenditore italiano è un uomo solo al comando: geniale, impulsivo, istintivo, accentratore; è spesso poco capitalizzato e fortemente dipendente dal credito delle banche. Quelli che sono i suoi principali pregi, tradotti in prodotti spesso inarrivabili, si trasformano in gravi difetti nella competizione ad alti livelli, dove serve un vero gioco di squadra, ferrea programmazione gestionale, distributiva e finanziaria, oltre ad una disponibilità di cassa rilevante. Non si spiegherebbe perché abbiamo, tra le tante eccellenze, la migliore pizza ed il miglior caffè del mondo, ma Pizza Hut e Starbucks non risultano essere di proprietà delle famiglie Rossi e Russo. E perché nessun connazionale sia mai riuscito ad imporre il nostro vessillo sulla diffusione dei nostri prodotti su scala mondiale. Allora, forse, dovremmo riflettere sul nostro modo di intendere il “fare impresa” e sul modello stesso dell’impresa familiare, troppo a lungo difeso sotto la sigla ingannevole di “small is beautiful”.
Altro aspetto fondamentale, di assoluta attualità, è di tipo finanziario: complice anche la massa di liquidità immessa di recente sui mercati, le grandi multinazionali stanno rastrellando risorse finanziarie attraverso l’emissione di obbligazioni societarie, i corporate bond. Risorse disponibili per programmi di crescita interna, certo; ma anche per programmi di acquisizione di altre aziende appetibili. Ebbene, le aziende francesi e tedesche pagano queste risorse ad un tasso di gran lunga inferiore rispetto ai competitor italiani, risultandone fortemente avvantaggiati. E qui ritorna, tra gli altri, il problema dello spread e della credibilità del sistema Paese.
Permettetemi infine di chiudere con una nota forse un po’ polemica ma molto sentita. L’impressione che si ha osservando le vicende di casa nostra è che gli imprenditori di primo piano siano troppo interessati agli intrecci con la politica e alla sterile difesa dello status quo. Risultano in questo senso incomprensibili le zuffe di questi giorni su RCS, tempio di un mondo e di un potere che fu. Il provincialismo è un lusso che non ci possiamo più permettere e salotti e talk show andrebbero avvicinati con una frequenza di gran lunga inferiore ai comitati strategici dell’azienda che si governa. Pianificare le proprie mosse sui mercati esteri, curare il processo produttivo e la distribuzione, innovare il prodotto, programmare le finanze è infinitamente più importante della percentuale acquisita in Mediobanca o della partecipazione ai dibattiti di Ballarò sui nostri eterni, irrisolti, problemi.



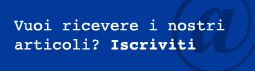
11 comments
adone paratore says:
Lug 12, 2013
Analisi e considerazioni che condivido in pieno. Era ora che qualcuno le dicesse con questa franchezza . Ottimo Michele.
igor leone says:
Lug 12, 2013
Complimenti per l’articolo le cui considerazioni condivido pienamente.
E’ davvero peccato che l’imprenditore italiano, che sa pensare e creare l’eccellenza in svariati campi, non sia poi abbastanza lucido da farsi aiutare per internazionalizzarsi e ingrandirsi per poter competere con le multinazionali.
Certo questo presuppone comunque che la mondializzazione sia la risposta giusta…forse l’imprenditore italiano ha la buona strategia, ma nel mondo sbagliato (il che porta comunque ad avere la strategia sbagliata).
Un altra domanda che mi sorge spontanea é: perché in Francia due grandi finanzieri/imprenditori (Arnault con LVMH e Pinault con PPR) hanno creato imperi del lusso su tutte le sue forme, ma in Italia nessuno ci abbia pensato/lo abbia attuato ?
Il problema in questo caso non può essere il sistema paese, ma più probabilmente la poca conoscenza della finanza internazionale che da i mezzi per poter creare certe multinazionali.
Michele D' Apolito says:
Lug 13, 2013
@ Igor Grazie per i complimenti. Credo che il problema sia la tendenza all’ipercontrollo, difficile da sconfiggere anche quando si raggiungono proporzioni importanti. Non tanto una questione di lucidità, ma di poca volontà di vedere oltre la siepe per la paura di perdere l’assoluto dominio della creatura.
david p says:
Lug 15, 2013
Nel processo di internazionalizzazione, è vitale certamente la finanza, ma anche l’organizzazione. Su entrambi questi punti (ma forse ancor più sul secondo) paghiamo un deficit culturale elevatissimo. Si tratta certamente come dice Igor di comprendere la necessità di “farsi aiutare”; ma anche di comprendere (e mi rivolgo in particolare alle PMI) che all’Estero non si può andare da soli con l’approccio del cavaliere errante, ma occorrono persone, strutture e strumenti. In misura magari contenuta e graduale, ma occorrono.
maxfal says:
Lug 12, 2013
E giorno dopo giorno le cessione aumentano: oggi sul Corriere della Sera appare la notizia della vendita di un altro marchio storico quello dei cioccolatini Pernigotti. Non occorre circondarsi da barricate o impedire operazioni commerciali di questo tipo , questo è vero, ma come ha detto Michele sono campanelli d’allarme che vanno interpretati. Non aggiungo altre considerazioni in merito, preferisco però riflettere su una cosa: ma davvero non si potrebbe immaginare la costituzione di fondi pubblici/privati o cordate di imprenditori italiani per trattenere nel made in Italy questi gioielli? se fossimo un po’ più nazionalisti come i francesi ….
Michele D' Apolito says:
Lug 12, 2013
@ Maxfal: personalmente non credo che sarebbe positivo un intervento, anche minoritario, del settore pubblico. Abbiamo un lungo trascorso con partecipazioni statali animate da tutt’altro intento che quello della difesa del nostro made in Italy.
Ne approfitto per precisare che l’ultimo inciso dell’articolo non era specificamente riferito a Loro Piana, ma ad altri personaggi che campeggiano sugli schermi e giornali con maggiore frequenza.
Il paradigma dell’imprenditore che ho tratteggiato è quello delle generazioni di 60-70-80enni, che hanno fatto grande questo Paese e che faticano a modificare il loro approccio assecondando il nuovo contesto. Le nuove generazioni hanno sicuramente maggiore consapevolezza della necessità del gioco di squadra e della programmazione di ogni passo. Proprio oggi, ho letto sul quotidiano di Cremona un segnale di senso inverso a questa tendenza: mi riferisco agli importanti step che sta compiendo il polo della cosmesi del territorio cremasco, che sta affrontando la globalizzazione in un’ottica proattiva ed al passo coi tempi.
maxfal says:
Lug 12, 2013
Io credo che una volta tanto dovremmo pensare ad un ruolo del settore pubblico in accezione positiva, alcune esperienze positive ci sono come Simest. Grazie a questa sono stati resi possibili tante operazioni industriali all’estero. Un ingresso ” a tempo” a fianco di privati sarebbe un volàno alla crescita. La sua presenza potrebbe essere mantenuta fino a quando la realtà produttiva non è in grado di riprendere il suo cammino da sola. Il Made in Italy si fonda su prodotti di qualità e soprattutto marchi, se cominciamo a regalarli all’estero così ci garantirà dalla concorrenza mondiale? Il caso della cosmesi è un discorso un po’ particolare: è un settore che riesce a sottrarsi più di altri alle competizioni dei paesi low cost ed ha marginalità di prodotto più alte rispetto ad esempio all’alimentare. Su Cremona si è formata una interessante aggregazione spontanea ma che necessita ora di una inevitabile evoluzione…reti di imprese, consorzio, etc
david p says:
Lug 15, 2013
Mi inserisco nel botta e risposta con una considerazione. Anche io non sono contrario in assoluto ad un intervento pubblico. Ma che sia intelligente e selettivo. A monte occorre una politica industriale che sappia individuare delle aree strategiche di intervento, considerata anche la scarsità delle risorse. E limitare al massimo il rischio di commistioni con la politica che sarebbero pericolosissime.
Da questo punto di vista, caro Max, sono un po’ scettico: di politica industriale non si vede nemmeno l’ombra da anni. Vedo il rischio di interventi random e mossi da interessi diversi rispetto al “merito industriale” delle aziende in questione. Tuttavia, sull’azione della Simest mi piacerebbe approfondire.
filippo guidantoni says:
Lug 13, 2013
Alla lista aggiungerei Pernigotti, magari non è lusso ma sempre un marchio significativo. Concordo principalmente sul “giochino” dello spread che permette di non giocare ad armi pari sul fronte indebitamento (non proprio un aspetto secondario nella vita di un imprenditore). Status quo, sterili e gridati dibattiti in televisione e litigi su RCS; unica soluzione è guardare a quei pochi spiragli di positività che troviamo in qualche piccola azienda italiana, poche realtà sperdute e così via. Il rammarico è che non siamo un paese che inizia da zero ma abbiamo già delle ricchezze. E invece se da un lato finiscono dei marchi storici dall’altra cerchiamo di avviare nuove iniziative; il problema è che ci sono già realtà storiche da rilanciare che invece ci lasciamo sfuggire.
Michele D' Apolito says:
Lug 13, 2013
L’elemento che più deprime l’attuale contesto, a mio parere, è l’assenza di una qualunque proposta che faccia buttare il cuore oltre l’ostacolo agli imprenditori di casa nostra. E mi riferisco al grande, ma anche al piccolo. Un esempio: ieri ero da un piccolo imprenditore che da due anni ha utili netti pari all’8% del fatturato, ha patrimonializzato l’azienda ed ora ha la possibilità di ampliarsi con un altro capannone. gli chiedo: perché non ci pensa? mi risponde: perché avrei da sostenere l’esborso per l’ampliamento ed in aggiunta recupererei l’investimento in troppi anni, pagando nel frattempo imposte ad aliquote del 45%…così la mia attuale tranquillità si trasformerebbe in tensione finanziaria e dipendenza dalle banche. No grazie. Come dargli torto?
Terry says:
Lug 30, 2014
.
ñïñ!!